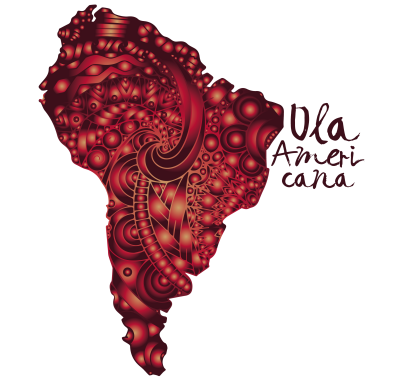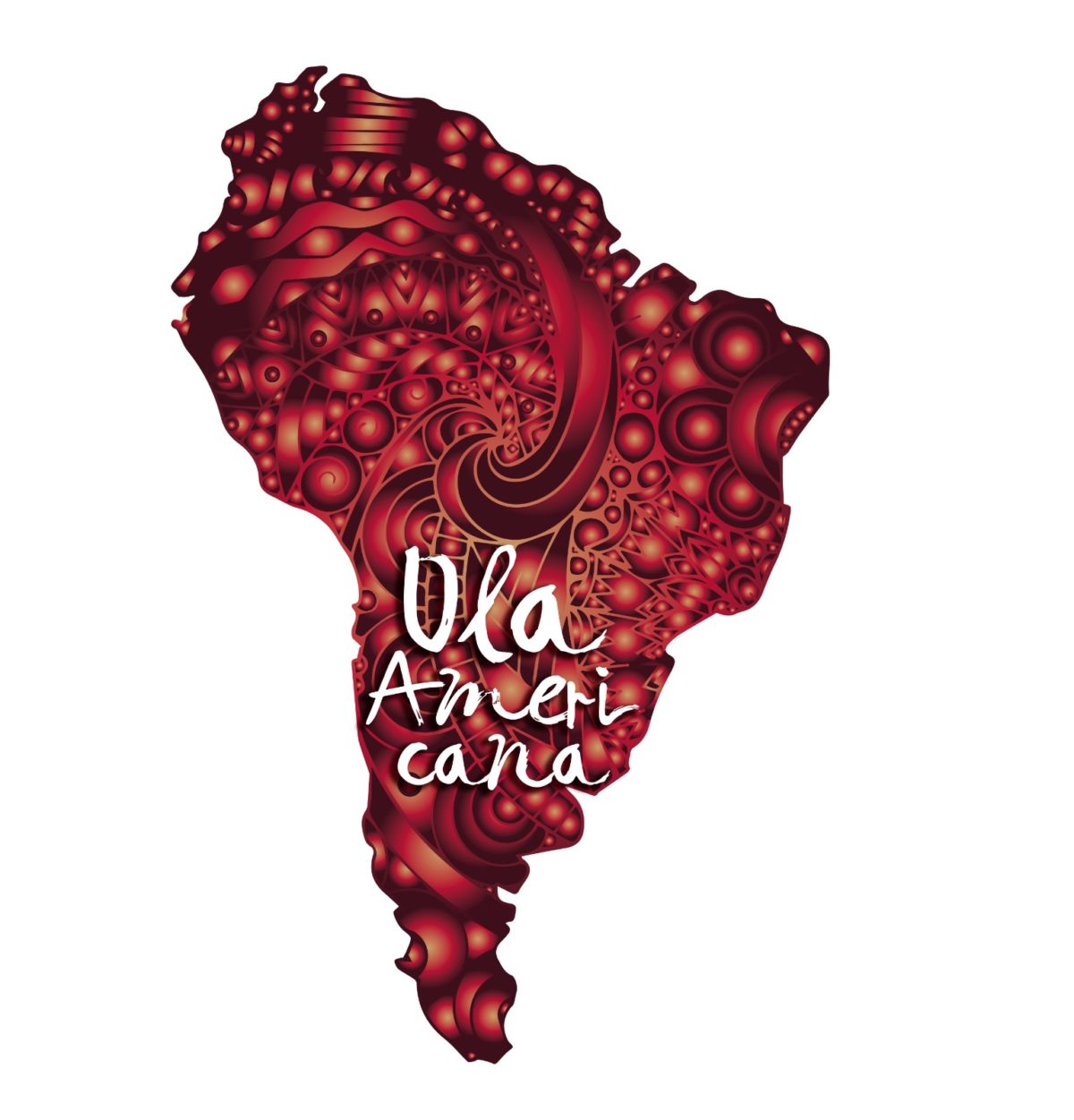Di Federico Larsen
L’America Latina affronta la pandemia del coronavirus segnata da una serie di fragilità strutturali che aprono seri interrogativi sul futuro. Se finora la maggior parte dei paesi è riuscito a limitare relativamente il contagio ed evitare in parte le scene terribili che arrivano dall’Europa e gli Usa, le condizioni socio-economiche, sanitarie, e la mancanza di una vera e propria coordinazione nelle azioni intraprese pongono oggi un serio interrogante sul futuro prossimo della regione.
Fino al 19 aprile in America Latina sono stati registrati 44.344 casi e 1738 morti (Canada Stati Uniti e Messico sono prossimi ai 450.000 casi e 15.300 morti). In questo contesto, gli stati hanno scelto approcci molto diversi. Si va dal negazionismo, sempre più fievole, di Bolsonaro in Brasile o Lopez Obrador in Messico, alla chiusura totale e preventiva dell’Argentina di Alberto Fernandez. Di certo, quest’ultima é la risposta più consigliata a livello internazionale, ma ci sono fattori locali nel subcontinente che la rendono estremamente difficile. L’informalità nel mondo del lavoro è sicuramente uno dei fattori che impedisce l’imposizione di misure drastiche per combattere la pandemia. Nei paesi latinoamericani e dei Caraibi il 48,4% dei lavoratori sono in nero, hanno lavori occasionali o non registrati. Per loro, un giorno in casa significa un giorno senza paga. In alcuni casi, come nella Città del Messico, la percentuale può superare il 60% e diventa proibitivo anche per il governo proporre misure di accompagnamento a queste famiglie. Per l’Argentina, il salario straordinario di 10.000 pesos (130 euro, il 60% del salario minimo) offerto a marzo a lavoratori informali e dei settori più colpiti dalla sospensione delle attività (ristorazione, commercio ecc…), triplica in un solo mese la spesa fiscale nazionale. Il governo colombiano ha distribuito un sussidio speciale di 160.000 pesos (circa 40 euro) a tre milioni di famiglie. Il Venezuela ha cominciato a distribuire 450.000 bolivares (circa 7 euro) tra i lavoratori informali, che rappresentano circa il 47% del totale. Le misure di emergenza significano, in tutto il mondo un aumento imprevisto ed esagerato della spesa pubblica, che gli stati non sono in grado di affrontare. Il tracollo delle esportazioni e la chiusura di settori vitali per l’economia locale fanno prevedere una caduta del 7% dell’economia della regione. Ed ecco che la pandemia ha accentuato una caratteristica sistemica del continente, la dipendenza economica dalle finanze internazionali, con le sue conseguenze e controversie. La Colombia ha recentemente chiesto un prestito di 11 miliardi di dollari al FMI. L’Argentina ha ricevuto nuovamente fondi dalla Banca Mondiale. Anche Nicolás Maduro, di fronte alla crisi dovuta al coronavirus ha chiesto al Fmi un prestito di 5 miliardi di dollari, negatogli perché non riconosciuto come presidente legittimo da buona parte dei governi che compongono il board dell’organismo.
L’altro aspetto della fragilità latinoamericana in questo frangente è sicuramente quello della sanità. In tutto il continente americano, solo cinque paesi hanno una spesa pubblica in sanità superiore al 6% del PIL, il minimo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: Cuba, Stati Uniti, Costa Rica, Uruguay e Canada. Nella maggior parte dei casi, la spesa totale è completata da un complesso sistema di assicurazioni private, mutue, trattenute obbligatorie in busta paga o spesa diretta a cambio di prestazioni ambulatorie. In media ogni abitante latinoamericano spende 1200 dollari l’anno in servizi sanitari. La struttura sanitaria poi, non è delle più efficienti. Secondo dati della Banca Mondiale esistono in media 2,2 posti letto ogni 1000 abitanti in America Latina e i Caraibi (in Europa secondo lo stesso database la media è del 6,4). Bisogna poi tener conto delle già pesanti condizioni sanitarie in cui versa l’America Latina da anni, a causa di malattie trasmissibili che sono già di per sé problematiche nella regione. Si tratta di patologie che i medici non dubitano a definire come sociali, che colpiscono principalmente i settori popolari e tendono ad avere picchi alti di contagio quando sono gli anticorpi sociali a mancare: lavoro, casa, igiene personale e comunitaria ecc… In America Latina, secondo dati del 2018 della Organizzazione Panamericana della Salute, sono stati registrati 760 mila casi di malaria, 561 mila casi di dengue, 3.900 casi di colera, 16.400 di morbillo, 1.400 di febbre gialla e 34.500 di lebbra. A questo si aggiungono 42 nuovi casi di tubercolosi ogni 100.000 abitanti per anno, la vera e propria “malattia dei poveri” che fa strage da Buenos Aires a Tijuana. Il tasso di mortalità a causa di malattie trasmissibili è di 80 deceduti per ogni 100.000 abitanti. Negli Stati Uniti o in Canada non supera i 30. Tutti questi indicatori si aggravano nei periodi in cui aumentano disoccupazione e povertà, un indice che negli ultimi quattro anni è in crescita in tutto il continente: la povertà raggiunge oggi il 30% della popolazione. Il 10,7% vive in condizioni di povertà estrema.
Insomma, un sistema arretrato, insufficiente, già sotto pressione a causa delle diverse epidemie presenti nel continente, in molti casi pesantemente privatizzato o dalle barriere più che evidenti, è chiamato ad affrontare una delle peggiori pandemie della propria storia. E in ogni paese, la politica ci mette del suo.
In questo frangente la grande incognita in America Latina è il Brasile. Il Sistema Unico Sanitario brasiliano era diventato nei primi anni 2000 un punto di riferimento per la nascita di strutture sanitarie moderne, pubbliche e accessibili, un sistema studiato e imitato in tutto il continente. Il paese è stato il primo a confermare un caso di coronavirus positivo lo scorso 26 febbraio, e da allora la curva di contagi è ormai una linea retta ascendente. Il presidente Bolsonaro si è schierato caparbiamente con chi vuole evitare ad ogni costo un rallentamento dell’economia a causa delle misure sanitarie. Ha snobbato i rischi legati al Covid-19 (che continua ancora a definire “il virus cinese”) ed ha esaltato la presunta indistruttibilità dei brasiliani (“possiamo nuotare nelle fogne che ne usciremmo senza nemmeno un raffreddore” ha sostenuto in conferenza stampa). Il Brasile è oggi il paese col maggior numero di casi confermati (16.000 al 9 aprile) e morti (800) dell’America Latina. Abbandonato dai suoi alleati del negazionismo globale, Trump e Johnson, obbligati a modificare drasticamente le loro scelte, il presidente brasiliano ha cercato di limitare al massimo le misure federali nel suo paese, accettando solo la chiusura delle frontiere, l’obbligo di distanza ai tavolini al bar, e proibire le crociere, ed è rimasto sempre più solo anche a livello domestico. Ministri, governatori, militari, hanno cominciato a prendere le distanze dal presidente e agire in conseguenza. L’ex ministro degli esteri di Lula e Itamar Franco, Celso Amorim, ha recentemente dichiarato che il problema nel suo paese è che non si sa chi governa nel bel mezzo della pandemia. Infatti sono sempre di più gli indizi di un vero e proprio divorzio della coalizione tripartita che sostiene Jair Bolsonaro. Il settore più duro è certamente quello dei militari, che controllano quasi la metà del gabinetto. L’esercito ha imposto a Bolsonaro un proprio membro, Walter Souza Braga Netto, come nuovo “ministro della casa di governo”, una sorta di primo ministro, e ha posto il veto al licenziamento del ministro della salute, Luiz Henrique Mendetta, che ha più volte contraddetto il presidente chiedento drastiche misure di isolamento sociale. Nello scompiglio di Brasilia, tutti i governatori hanno imposto la quarantena nei propri territori, e addirittura la criminalità organizzata di Rio si incarica di fare in modo che nelle favelas tutti rimangano in casa per evitare i contagi, vista l’inazione dello stato. L’affaire Mendetta e la sottovalutazione del coronavirus, hanno allontanato Bolsonaro dallo zoccolo duro del potere governativo che include, oltre ai militari rappresentati da Netto e dal vicepresidente Hamilton Mourao, anche il ministro dell’economia Paulo Guedes e quello della giustizia Sergio Moro. Contrari alle scelte presidenziali anche il 76% dei brasiliani e la maggioranza delle autorità del parlamento, con cui “Il Capitano” manteneva già una battaglia aperta per l’approvazione delle sue riforme in senso ultra conservatore. Il Clan Bolsonaro -che include i figli e gli irriducibili trincerati nel ministero degli affari esteri- si è rifugiato tra le braccia dell’unico settore ancora fedele e potente, quello delle chiese pentecostali. C’è chi parla di impeachment, chi addirittura di golpe o destituzione. Ma secondo la costituzione se Bolsonaro non conclude almeno metà del suo mandato, cioè se non arriva al 1 gennaio 2021, bisogna sciogliere le camere ed andare a nuove elezioni, con grandi possibilità per la sinistra del PT di tornare al potere. Uno scenario che, in piena pandemia, non conviene a nessuno.
Alcuni governi, come quello argentino, hanno invece colto l’occasione per cercare di migliorare la propria posizione a livello domestico e nel sistema internazionale. Il presidente Alberto Fernandez ha imposto un duro protocollo sanitario sin dall’inizio della diffusione del virus in tutto il paese. Dopo il diciassettesimo caso confermato ha fatto chiudere tutte le scuole, e dal 20 marzo è in vigore la quarantena sociale obbligatoria di tutta la popolazione. I bollettini giornalieri difficilmente superano i 100 contagi al giorno, e il numero di morti è anch’esso relativamente contenuto. Questo ha dato modo al debole sistema sanitario di guadagnare tempo e prepararsi in vista del picco della curva di contagi prevista a maggio. Una serie di misure che hanno rapidamente accresciuto la popolarità e fiducia nel governo insediatosi appena quattro mesi fa, e che si è anche mosso a livello internazionale. A fine marzo, nel mezzo dell’emergenza, è riuscito ad ottenere il beneplacito dei creditori interni ed esteri per posticipare unilateralmente le scadenze di una parte del proprio debito -circa 10 miliardi di dollari- sino all’anno prossimo. Slittati anche i pagamenti al Fondo Monetario Internazionale, che all’Argentina ha concesso il prestito più grande della sua storia: 44 miliardi di dollari nel 2018. Ma non solo. L’Fmi ha addirittura pubblicato un documento ufficiale in cui esorta gli investitori di titoli argentini ad accettare un condono del debito compreso tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari, quasi un terzo del totale. L’avvicinamento tra il governo di Buenos Aires e la grande finanza mondiale, che fino a pochi mesi fa vedeva nel nuovo esecutivo peronista un possibile nemico, è stato consolidato col nuovo prestito di 300 milioni di dollari elargito dalla Banca Mondiale lo scorso 25 marzo. Si sa, in tempi di pandemia si è più spinti verso la generosità, ma la fiducia ottenuta e dimostrata a gesti clamorosi da parte degli organismi finanziari internazionali non fanno altro che rafforzare la posizione argentina di fronte ai creditori privati, principale problema del paese nel post coronavirus. Galvanizzato dal successo riscosso in quel frangente, e dalla inaffidabilità dimostrata dai suoi soci latinoamericani nel G20 (Brasile e Messico), Alberto Fernandez si è addirittura eretto a rappresentante della regione nella riunione dell’organismo via teleconferenza del 25 marzo. In quell’occasione ha proposto la creazione di un fondo umanitario di emergenza per affrontare la pandemia, accolto con freddezza dagli altri capi di stato e di governo, ma certamente utile all’argentino come carta di presentazione da attore con iniziativa per le prossime riunioni.
Questi due casi, quello argentino e quello brasiliano, mostrano l’enorme diversità di approcci di fronte al coronavirus in una regione storicamente accomunata da legami culturali, politici, commerciali. Oggi però ogni paese guarda al proprio vicino con certa apprensione, ben sapendo che la chiusura di frontiere è quasi solo retorica vista la permeabilità storica di cui hanno sempre risentito. Se non si possono controllare con certezza gli spostamenti però, la strada più logica da intraprendere sarebbe quella del coordinamento di azioni per attutire l’impatto della circolazione del virus. Ma anche qui è notevole la fragilità sudamericana.
Nell’aprile del 2018 Argentina, Brasile, Colombia, Chile, Paraguay e Perú hanno messo la pietra tombale sull’ultima iniziativa corale di integrazione regionale dell’America meridionale, l’Unasur. Nel suo seno funzionavano l’Unasur Salud e l’Istituto sudamericano di Governo sanitario, organismi che, per la prima volta, avrebbero permesso di accomunare criteri e sforzi sotto un ombrello internazionale con l’appoggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e la sua versione Panamericana. L’Unasur, considerato modello d’integrazione troppo ideologizzato durante l’exploit dei governi conservatori durante gli ultimi anni, è stato smantellato per far rientrare le questioni diplomatiche latinoamericane negli argini storicamente stabiliti: quelli dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), sotto controllo statunitense. Finora, l’unica iniziativa presa dall’OSA dall’inizio della pandemia è stata la rielezione del segretario generale Luis Almagro, garante dell’indirizzo favorevole a Trump, in una clamorosa sessione straordinaria svoltasi a Washington tra mascherine e guanti di latex, in barba alle disposizioni locali avrebbero proibito una riunione simile. La fragilità sudamericana di fronte alla pandemia si vede anche in questi aspetti.
L’America Latina potrebbe quindi uscire dalla pandemia più indebitata, più indebolita, e più disintegrata di come ci è finita. In diverse parti del mondo si parla ormai di un punto di inflessione a partire dal quale bisognerà rivedere le norme del sistema politico e finanziario internazionale, oltre ai drastici cambiamenti richiesti nei comportamenti di stati e cittadini. Il futuro del Sudamerica dipenderà in buona dose dalla natura di quei cambiamenti, dal grado di impegno che i governi dei paesi centrali decideranno di assumere, e soprattutto dal ruolo che gli stati latinoamericani vorranno avere in questo processo. L’inclusione di Messico, Brasile e Argentina nei summit del G20 dopo la crisi del 2008 hanno dimostrato che non basta partecipare e fare bei discorsi per incidere sulle dinamiche globali. In quel caso l’America Latina ha portato a casa un aumento nella partecipazione azionaria nel board del Fmi. Nulla da mostrare ai lavoratori informali, al sistema sanitario, né da condividere coi propri vicini. Eppure, purtroppo, le condizioni attuali non fanno presagire nulla di buono per il subcontinente nel post-coronavirus.